COLLABORAZIONI
In questo Settore vengono riportate notizie
e immagini fornite da altri redattori.
Nello specifico, il presente articolo è stato realizzato
da Giancarlo Gualtieri, Presidente dell'A.I.C.I.S., che ha fornito anche le immagini.
Tutti gli articoli degli altri Settori sono state realizzati
da Patrizia di Cartantica che declina ogni responsabilità
su quanto fornito dai collaboratori.
"N.B.: L'Autore prescrive
che qualora vi fosse un'utilizzazione per lavori a stampa
o per lavori/studi diffusi via Internet, da parte di terzi
(sia di parte dei testi sia di qualche immagine) essa potrà
avvenire solo previa richiesta trasmessa a Cartantica e citando
esplicitamente per esteso il lavoro originale (Autore, Titolo,
Periodico) ."
******
ICONOGRAFIA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA NELLE IMMAGINI SACRE: INCISIONI E "SANTINI"

Fig. 1
|

Fig. 2
|
Sono due i dipinti che, secondo i biografi del Santo, furono usati come archetipi da molti artisti ed incisori del XVI e XVII secolo per realizzare numerosi ritratti del Santo.
Il primo dipinto, di autore ignoto del XVI secolo, si trova nella chiesa di S. Francesco di Paola (o dell’Annunziata) di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza (fig. 1).
Il Santo è ritratto a figura intera su uno sfondo d’oro stellato con il caratteristico saio dei minimi, il bastone tra le mani e gli zoccoli ai piedi. Questo dipinto sarebbe la copia di quello fatto al Santo dal vivo nel 1483, mentre soggiornava a Napoli presso la corte del re Ferrante d’Aragona durante il suo viaggio verso Tours in Francia.
La leggenda vuole che il bravo pittore, non ottenendo che il Santo posasse dinanzi a lui, eseguisse l’opera osservandolo attraverso la fessura della porta della sua stanza.
La raffigurazione del dipinto si ritrova nel corso dei secoli successivi in molte incisioni e soprattutto, con diverse varianti, in tantissimi santini in bianco e nero (B/N) ed in cromolitografia del XX secolo (fig. 2).
|
Il secondo dipinto lo eseguì il pittore francese Jean Bourdichon (1457-1521), autore anche della più antica immagine che ritrae il beato Francesco dinanzi alla madre di Dio (fig. 3). Questi realizzò l'opera utilizzando la maschera funeraria di gesso del volto del Santo, che è senz’altro il ritratto più verosimile di San Francesco di Paola. Il dipinto, donato al Papa Leone X dal re di Francia Luigi XII in occasione della canonizzazione di Francesco, è purtroppo andato disperso. Fu, però, ripreso da incisori famosi come F. Villamoena (1526-1624) e M. Lasnè (1590-1667).
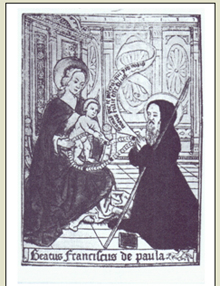
Fig. 3
|
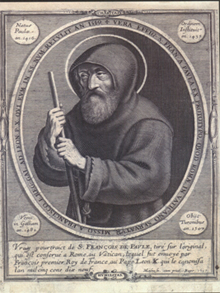
Fig. 4
|
Nell’incisone del Lasnè il Santo è ritratto in un ovale a tre quarti, si poggia con ambedue le mani sul suo bastone ed indossa il classico saio con cappuccio del suo ordine. Il volto arcuato evidenzia un naso aquilino e una lunga barba.
Ai lati in quattro cerchi sono riportate le principali date dellasua vita:
• 1416 anno della sua nascita
• 1435 anno dell’istituzione del suo Ordine
• 1482 anno della sua venuta in Francia
• 1507 anno della sua morte.
In basso la scritta con il nome dell’autore M. Lasnè e l’anno in cui l’incisione fu eseguita: 1645. Nella cornice intorno all’ovale è riportata la scritta: “Vero ritratto di S. Francesco di Paola, eseguito dall’originale, che è conservato a Roma, in Vaticano, che fu inviato da Francesco primo, Re di Francia, al Papa Leone X che lo canonizzò l’anno 1519”. Al centro della cornice che racchiude l’incione in due piccoli cartigli sono riportate le due principale regole del suo ordine “CHARITAS” ed “HUMILITAS” (fig. 4).
Anche questa immagine fu ripresa successivamente in molti dipinti e vari santini (fig. 5). |
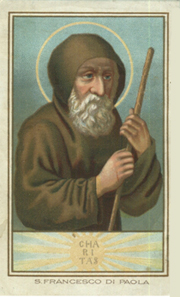
Fig. 5
|
Nel corso del VI e XVII sec. si hanno diverse raffigurazioni del Santo soprattutto nei libri che narrano la sua Vita o nei Leggendari delle Vite dei Santi: si tratta soprattutto di xilografie od incisioni a volte acquerellate a mano (figg. 6 - 7). |

Fig. 6
|

Fig. 7
|
Nella seconda metà del XVII secolo incominciano a circolare in Europa i preziosi santini manufatti, i cosiddetti “canivets” (dal francese canif il temperino usato per intagliarli, eseguiti su commissione da abili artisti o pazienti monache di clausura.
Un bellisimo esemplare raffigurante “San Franciscus de Paula” si trova, insieme ad altri diciannove canivets di altri santi, presso l’altare della cappella nobiliare dei Ruffo nel convento dei Cappuccini di Francavilla di Sicilia in provincia di Messina.
L’immagine del Santo dipinta a mano, un po’ sbiadita dal tempo, si trova al centro di una doppia cornice in un ovale, da cui si diramano minutissimi intagli floreali che imitano i motivi decorativi dei merletti. Molti i santini che a questo si richiamano (fig. 8). |
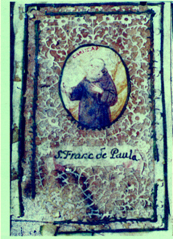
Fig. 8
|
Nel corso del XIX secolo la carta prende gradualmente il posto della pergamena e si perfezionano le tecniche di stampa, per cui si riproducono gli antichi canivets: nascono i cosiddetti santini di “pizzo”, contribuendo ad una enorme diffusione del santino.
Le case tipografiche più importanti sono soprattutto in Francia come la Bousse Lebel , la Lamarche o la Turgis, (fig. 9).
In seguito, grazie alla tecnica della cromolitografia, si ha una grande produzione di santini anche in Italia, che vengono stampati sino ai primi decenni del XX sec. da grandi case editrici come la Litografia San Giuseppe di Modena o la Santa Lega Eucaristica di Milano (fig. 10). |
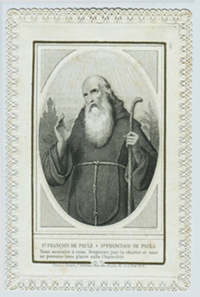
Fig. 9
|

Fig. 10
|
La gran parte delle incisioni e dei santini sono riconducibili alle opere eseguite da grandi artisti, ma è un ardua impresa farne un elenco completo sebbene io ne abbia catalogate diverse centinaia di varianti, per cui riporto di seguito solo alcuni esempi:
• incisione dipinta dal Montbugnoli, disegnata dallo Spagnoli ed incisa da L. Paradisi, in cui compare il Santo raccolto in preghiera con le mani giunte (fig. 11), e ripresa in vari santini in cromolito (fig. 12); |
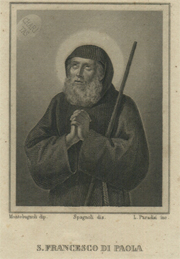
Fig. 11 |
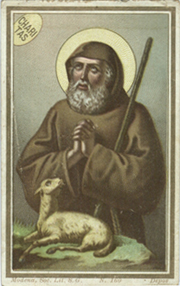
Fig. 12 |
• santino in B/N (fig. 13)
• cromolito (fig. 14), di B. E. Murillo (1617-1682); |
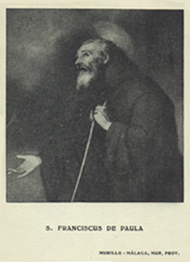
Fig. 13
|

Fig. 14
|
• santino a colori (fig. 15), da un ritratto di Luca Giordano (1634-1705)
• santino a colori (fig. 16), dal ritratto di G. Bauli, detto il Baciccia (1639-1709) presso la chiesa di S. Rocco all’Augusteo in Roma; |

Fig. 15 |

Fig. 16
|
• santino a colori (fig. 17), da un ritratto di U. Gandolfi (1728-1781) presso la chiesa della Maddalena in Bologna;
• santino in B/N (fig. 18), dal ritratto di G.B. Salvi detto il Sassoferrato (1605-1682) presso la chiesa di S. Francesco di Paola ai Monti in Roma. |

Fig. 17
|
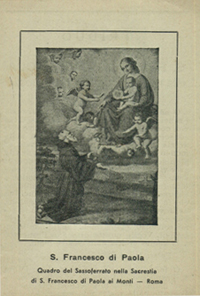
Fig. 18
|
Dello stesso Autore:
e in Collezionismo:
|